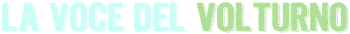CONTINUA IL RACCONTO DELLO SCRITTORE CASTELLANO VITTORIO RUSSO “SULLE ALI DEL MITO”

TERZA PUNTATA
Wendy non ha smesso un attimo di chiedermi, più per leziosità che per effettiva curiosità culturale, notizie sulla Pizia, chi fosse, che età avesse, con chi se la facesse (!) e banalità del genere. Laurentìa mi ha spesso tratto d’impaccio con risposte esaurienti e definitive invitando per gioco, lei come gli altri, a seguire le procedure e consultare ciascuno il proprio “oracoloâ€, precisando che il vaticinio sarebbe stato manifestato da un segno del quale ciascuno avrebbe dovuto intendere il senso. Qui, ha ricordato, si venivano a implorare responsi sui grandi temi della vita e della morte, della vittoria gloriosa e della sconfitta fatale, dell’amore e dell’odio, ma si veniva pure per chiedere alla Pizia dove fondare una colonia, quando e chi dovesse essere l’oikistes, il capitano che avrebbe guidato la spedizione. Qui si veniva per interrogare il Fato sulle banalità della vita quotidiana. Lo si faceva con il massimo impegno e la più profonda convinzione di cui è sempre capace la natura umana. Qui si veniva infine per chiedere al destino se intraprendere una guerra e quando. E qui, forse, si è pure decisa la sorte del nostro divenire, perché la battaglia di Salamina, punto di svolta della nostra civiltà , fu a quanto pare, decisa proprio dall’Oracolo di Delfi. Esso aveva predetto che dopo le più atroci sofferenze, a difendere la libertà di Atene avrebbero provveduto mura di legno. Le mura di legno erano, secondo l’interpretazione, le trireme della flotta ateniese che Temìstocle aveva caparbiamente voluto e con le quali aveva affrontato nello stretto di Salamina la sterminata flotta di Serse e l’aveva distrutta.
Prendendomi in giro mi sono prestato al gioco sacro profanandolo, e ho chiesto una predizione agli dèi fantastici del passato…
Mi sono soffermato a lungo a veder scorrere le acque scarse di un torrentello che scaturivano da un mucchio di sassi anneriti dal tempo. Era questa, nientemeno che la celeberrima fonte Castà lia, sacra alle Muse, appena all’ingresso dell’area sacra del tempio. Castà lia, figlia del fiume Achelòo, secondo il mito, si gettò nelle acque della sorgente per sfuggire alle attenzioni morbose di Apollo. Da allora la fonte prese il suo nome. Le sue acque servivano per mondare coloro che qui venivano a consultare l’oracolo del dio. Si racconta pure che quelle acque ispirassero la poesia a coloro che le bevevano… Mi sono purificato le mani e la fronte con poche gocce e me ne sono umettato le labbra con un dito bagnato. In altri tempi avrei sacrificato una capra ad Apollo. Mi sono fermato, invece, in silenzio, nell’attesa molto dubbiosa e quasi provocatoria di un segno. In alto, oltre la Roccia della Sibilla verde di licheni, di edera e di ciuffi di capperi selvatici, il vento dominava sovrano brontolando tra i rami degli allori sacri ad Apollo. Solo il suo frullare mi distraeva e non mi dispiaceva, mentre avanzavo lungo l’insigne pietra. Poi, qualcosa m’è piovuta sui capelli. Istintivamente ho allungato le dita di colpo per liberarmene. Mi sono trovato nella mano un sottile rametto di foglioline verdissime con appiccicati alcuni bozzoli, come crisalidi vuote, e un ciuffetto di bambagia bianco-viola: il fiore di un cappero selvatico che ha perduto immediatamente i suoi filamenti tra le mie dita.
Un segno?
I segni sono il destino di Delfi per l’eternità . E l’oracolo non ha altra voce se non quella di un segno da interpretare. A essi gli antichi annettevano un’importanza capitale. Il semplice stormir di fronde di una quercia diventava la voce viva di un dio dalla quale si traeva una premonizione. Ma ha un senso, oggi, per noi tutto questo? Qui, a Delfi, mi piace crederlo, non fosse altro che per gioco. D’altronde che costa? Mi fa essere certo di aver avuto, fra le altre, anche quest’inconscia ragione a motivare la mia escursione di oggi e la mia ricerca di qualcosa di sempre… Mi son pure domandato se non fosse blasfema la banalità ludica del mio oracolo. Ecco, io la ponevo nella stessa prospettiva delle profezie antiche sui grandi temi della vita e della morte, di esseri come me, che qui credevano di svelarla percorrendo il solco tracciato dal dito del Fato. Mi son chiesto se fosse opportuno prendersi gioco della sacralità che circondava responsi che hanno determinato il destino degli uomini, le decisioni di grandi battaglie e le immense stragi che hanno mutato la sorte del mondo. Ma pesa così poco la mia povera dimensione di viandante lungo i sentieri del passato che forse mi è consentito per celia di trastullarmi con il fluire stesso della vita. Per la mia cultura essa è un solco non tracciato da nessun aratro. Ammutolisco però, rispettoso, di fronte alla visione che del mistero dell’esistenza aveva l’uomo antico e non solo quello. Di quest’uomo dal cuore innocente ho venerazione. E qui riesco a vederlo con occhi che non sanno invecchiare.
Nel museo, poco distante dal sito archeologico si conservano interessanti frammenti e reperti, alcuni di estremo valore. Pochi oggetti, è vero, ma è tutto quello che resta della profusione di ricchezze e di doni di cui erano stracolmi i tesori del santuario. Mi piace, in particolare, ricordare il gigantesco capitello d’acanto su cui danzano tre dee velate e il celeberrimo Auriga di bronzo dal purissimo profilo, donato al Santuario da Polyzalos, tiranno di Gela.
Il ritorno ad Atene è durato un’eternità . Ho chiuso gli occhi riandando alle immagini della giornata, tante molte deludenti, sghembe, aguzze come sassi sotto suole sottili. Esse hanno profanato i modelli che le conoscenze libresche vi avevano fissato in maniera irriducibile e alle quali so guardare solo con occhi che non hanno il senso del tempo.
I sognatori non dovrebbero visitare la Grecia se privi di una robusta corteccia di pragmatismo. E così, mentre malinconico riflettevo, nel sedile accanto, Wendy, estenuata ormai, sonoramente russava beata per la retsina, il vino aromatizzato, bevuto senza parsimonia durante la breve colazione… Mi sono corsi alla mente i versi di Carducci, quelli dell’asin bigio che: rosicchiando un cardo, rosso e turchino, non si scomodò: tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo e a brucar serio e lento seguitò.
È ormai quasi buio quando raggiungo il ristorante dove ho appuntamento con Laurentìa, con Wendy e i due spagnoli per una cena alla maniera greca. È tutto così diverso in questo locale e gli aromi di cui l’aria e impregnata mi sono indistintamente noti. Mi sento lontano e fuori dal tempo. Ma non mi stupisco, so che le distanze storiche spesso, per una sorta di simpatia, finiscono per coinvolgere talvolta anche il tempo e stravolgerlo accrescendone o riducendone le lunghezza.
Anche questa mattina di lunedì la sveglia suono a un’ora impossibile. Qui sono le sei, le cinque del mio tempo. Mi sono scosso anche qualche minuto prima che squillasse la suoneria del mio telefonino. Solo una ciotola di yogurt e di miele per colazione. Lo yogurt è quello denso che sa di panna e di latte di capra e che si amalgama perfettamente col miele, il miele greco naturalmente, quello di Creta o dell’Imetto, che sto cercando affannosamente per portarne via un vasetto.
Il pullman è fuori in attesa, già in moto. Ci sono poche persone per questa escursione. C’è la guida, Marianna, dal volto lucente di abbronzanti e incorniciato da un pagliaio di capelli efferveÂscenti, una coppia di ucraini, i coniugi Nagorniuk, bianchi di età e viola di acciacchi nella pelle dei volti. Lui, professore di greco antico, non ha smesso un attimo di porre domande in questa lingua, lei, due occhi costantemente sgranati e sovrani come di chi è testimone di un miracolo, ma che sembra votata all’ascolto. Ci sono poi quattro anonimi americani e due ragazze francesi non meno anonime. Siamo partiti intorno alle sette imboccando l’autostrada per Corinto. A circa dieci chilometri da Atene passiamo non lontano dal monastero bizantino di Dafni, costruito nell’XI secolo. Sorge sul luogo dove un tempo si levava superbo un santuario di Apollo, distrutto dai Goti intorno al quattrocento d.C., che richiamava il mito di Dafne amata dal dio e trasformata in alloro.
Proseguendo giungiamo all’altezza di Elèusi. Ho scorto appena quello che resta del tempio dedicato ad Afrodite, nascosto per strana coincidenza proprio tra ciuffi di mirti sacri alla dea, mazzi di canne, piccoli alberi di citiso dai fiori gialli a grappoli, frammenti anneriti di marmi antichi e pietre gialle frantumate dal sole e dal tempo. Elèusi è oggi un annebbiato sobborgo di Atene con fumose raffinerie di petrolio. Difficile immaginare che questa fosse la città sorta intorno a uno dei santuari più celebri del passato, dedicato a Demètra, la dea della vegetazione. Era un luogo sacro antichissimo, tanto da poterlo far risalire alla civiltà micenea e centro dei celebri misteri che tanta stupefazione e desiderio di conoscenza suscitavano nelle masse. Qui i fedeli venivano in processione percorrendo la lunga Via Sacra e passando per l’omonima porta del Ceramico, come ho detto prima. Di tutto questo non restano che i ricordi storici e il nome evocatore della città , perché la realtà geografica è paurosamente desolante.
Si prosegue sull’affollata autostrada dove il traffico diventa sempre più intenso a mano a mano che ci avviciniamo al canale di Corinto. Si avvicendano case bianche e chiese ortodosse di mattoni rossi. Queste sono sormontate da piccole cupole e campanili snelli come minareti, marcati da trifore e terminanti di regola con quattro colonnine bianche sotto un tetto leggero. Ai lati della strada si succedono cipressi di un verde cupo, allegri fichi, e lauri severi. Di tanto in tanto si notano dei tabernacoli colorati, come degli ex-voto, a ricordare morti violente in incidenti stradali. A sinistra, sul golfo di Mègara, si erge dal mare, ingobbita e azzurra per la lontananza, la sagoma di Salamina, l’isola dell’omerico Aiace Telamonio, cugino di Achille. Appare come un enorme granchio in procinto di serrare tra le sue chele il celeberrimo luogo della battaglia. In questo golfo, sotto i miei occhi, lì, proprio in quello stretto che fisso in lontananza, lì dove sembrano chiudersi le chele ebbe luogo la più straordinaria battaglia navale dell’antichità . È quella che vide i Greci di un testardo ammiraglio ateniese, Temìstocle, frantumare l’orgoglio persiano di Serse.
Correva l’anno quattrocentottanta prima del nostro evo.
Salamina: mi si gonfia il cuore in petto al ricordo che mi corre alla memoria. Per quanto mi arrampichi con l’immaginazione, non riesco a mettere a fuoco la dimensione di orgoglio di un popolo, quello di Atene, che con determinazione accetta il sacrificio di lasciare la città , le sue case, i suoi templi, i suoi monumenti abbandonandoli all’odio ottuso di un despota che tutto distrugge al suo passaggio, senza lasciare una sola pietra intatta. Ma quello di Atene era un popolo incapace di contenere il suo cocciuto orgoglio e la sua ostinata certezza di superiorità . Complice la disperazione estrema, attese per riscattarsi. E il riscatto fu una tra le più folgoranti vittorie navali di tutti i tempi. Un testimone di rilievo come Eschilo che alla battaglia di Salamina partecipò, riporta in righe di vivida forza i momenti di questo scontro. Seduto sul suo trono d’oro, sulla terraferma, Serse osservava sgomento la clamorosa disfatta e l’affondamento della più poderosa flotta dell’antichità , la sua, sfondata dai rostri di bronzo delle agili trireme di Temìstocle. A Salamina, come a Maratona dieci anni prima e a Platea un anno dopo, si erano scontrati due modelli di vita e di società , due concezioni dell’esistenza, due civiltà antagoniste. Da una parte quella ateniese con l’essenzialità della democrazia e della libertà conquistate con fatica dopo rivolte e storici tirannicidi. Dall’altra, il modello persiano che a tutti gli altri valori anteponeva quello dell’obbedienza fedele e della soggezione all’autorità di sovrani, signori della vita stessa dei sudditi.
Salamina: una pagina di storia capitale che segnando il trionfo dell’ideale politico e culturale greco nel mondo antico, inoppugnabilmente decise pure il divenire della civiltà occidentale.
Il viaggio è proseguito per Mègara, la magnifica, la città di Teognide il poeta, la città da cui partirono i coloni che fondarono Mègara Iblea e Selinunte in Sicilia e Bisanzio sul Bosforo. Segue subito dopo, a breve distanza, Corinto. Passiamo sul canale stretto, tagliato nel tufo giallo, polveroso e ci arrestiamo subito dopo per la sosta di un caffè.
Siamo ora nel Peloponneso, la terra di una dinastia di mitici eroi le cui sciagure sono la più cupa e contorta vicenda del Fato. La terra prese il nome da Pélope, lo sventurato capostipite, le cui scelleratezze coinvolsero il destino dei figli, Tieste e Atrèo e poi quello di Agamennone, che di Atrèo era figlio, assassinato da Clitennestra, e dopo di lui, del figlio Oreste che uccise sua madre per vendicare il genitore e finì perseguitato dalle Erinni, le dee della vendetta, fin quando non l’assolse il tribunale dell’Areopago…
Il pullman ha seguito la strada panoramica che corre lungo la costa fino a Nà uplia, passando per la baia di Kechriès. Qui sbarcò Paolo di Tarso che a Corinto visse e per diciotto mesi predicò la continenza, senza successo, a gente che amava in maniera somma la vita dell’al di qua e ne godeva con tutti i sensi. Da Kechriès si prosegue via via nel profumo intenso dei pini che fanno bello il paesaggio, fino alla nuova Epidauro. Poi volgiamo verso l’interno per raggiungere le rovine della città antica. Era questo il luogo sacro per eccellenza ad Asclèpio, il dio guaritore che si contentava dell’offerta di un gallo per le guarigioni che effettuava. Arriviamo nel sito archeologico con un sole splendente e un cielo terso che, per quelle concomitanze proprie di questa terra, trova conferma in tutte le impressioni di viaggio. Epidauro è solare, luminosa, il simbolo stesso del sorriso, dell’ottimismo e della resurrezione alla vita come dopo una guarigione.
Stando al mito, Asclèpio – Esculapio per i Romani – era figlio di Apollo e di Corònide che lo diede alla luce mentre bruciava su un rogo per vendetta di Artemide. Affidato al centauro Chirone, il piccolo apprese l’arte della medicina che espresse poi con tanta perizia da soppiantare il padre Apollo nel culto che gli era proprio e che qui gli era riservato da un tempo remotissimo. Era così esperto Asclèpio nella sua arte che più nessuno moriva. Ade stesso, signore dei morti, dovette chiedere l’intervento di Zeus perché l’ordine naturale fosse ristabilito. Il serpente divenne il simbolo di Asclèpio che con esso viene normalmente rappresentato mentre si appoggia a un bastone intorno al quale un pitone, appunto, avvolge le sue spire. Il serpente, è un’allegoria della rinascita, forse per via delle mutazioni della pelle, simbolo di resurrezione o per l’uso terapeutico del suo veleno. E il caducèo (che può essere tradotto come messaggero), il bastone con due serpenti intorno a esso attorcigliati, è divenuto così il simbolo della medicina.
Il santuario qui eretto era famoso nell’antichità e frequentato da pellegrini e malati che vi accorrevano da tutta la Grecia e da fuori. Era per qualche verso anche un luogo di cura. Vi sono stati rinvenuti, infatti, strumenti chirurgici tra i quali si distinguono bisturi di varie forme, raschiatoi, strigili, aghi eccetera, tutti ben conservati nel museo. È noto che la terapia fondamentale era affidata al potere della mente sul corpo e alle suggestioni che potevano venire dal dio ai pazienti durante il sonno. Tuttavia qui, nel santuario-ospedale, si praticavano pure interventi chirurgici complessi e si seguivano cure, molte delle quali sicuramente efficaci grazie anche alla salubrità del luogo. Notevole era la considerazione che si aveva per l’igiene. Non a caso, figlia di Asclèpio era Igiea, dal quale derive il termine.
Non resta molto del tempio dedicato al dio della medicina, solo scheletriche fondamenta. Ma è da notare la loro posizione e l’esposizione alla luce. Immaginabile che la costruzione fosse immersa nel verde balsamico di pini secolari perché i pazienti ne traessero il massimo beneficio. Nel museo sono raccolti, oltre agli strumenti chirurgici di cui ho detto, statuine di vario genere, sicuramente degli ex-voto, e oggetti votivi in genere.
Se folle incredibili visitavano il tempio di Asclèpio in cerca di guarigione, non minori erano quelle che vi accorrevano richiamate dallo splendido teatro del II sec. a.C. Capace di contenere circa quindicimila persone, era uno dei più capienti dell’antichità . Perfettamente conservato fino ai giorni nostri, esso è ancora utilizzato per rappresentarvi tragedie di autori antichi e manifestazioni artistiche di vario tipo. Celeberrimo per l’acustica, ne ho avuto una prova sedendo sulle gradinate più in alto, mentre Marianna, la guida, faceva cadere una monetina sulla pietra di marmo al centro della scena. Se ne avvertiva perfettamente il tintinnio alla distanza, così come il sussurrio della voce nel cavo delle mani. Semplicemente straordinario!
Da Epidauro siamo partiti intorno alle undici giungendo dopo poco a Nà uplia sull’omonimo golfo.
Nà uplio, figlio di Poseidone e Nà uplia, una delle cinquanta Danà idi, stando al mito fu il fondatore della città . Oggi è un centro moderno ed elegante, con l’ampia piazzetta schiusa sul mare argolico come a riceverne l’abbraccio. È dominata dalla fortezza veneziana di Palà miti dai mille scalini e sospesa in alto quasi oltre le nubi, mentre rosso sorge in mezzo al golfo il fortino di Bourtzi, esso pure risalente al periodo della dominazione veneziana.
Abbiamo avuto appena il tempo per un antipasto veloce. Ero sovrappensiero mentre sorseggiavo la mia bibita. Nel rumore confuso della strada ho sentito lontano, da una finestra, un vocione montanaro, vagamente femminile, urlare un nome: Ifigenìa, Ifigenìa… Era una voce vibrante di preoccupazione sanguigna cui ha fatto eco una sgarbata una voce adolescente. Non credevo alle mie orecchie. Un’altra tragedia, ho pensato per un attimo, assorto com’ero? Ma, Ifigenìa chi? Ho scoperto, e non c’è voluto molto, che la voce adolescente apparteneva a una ragazzetta rossa e lentigginosa. Un’Ifigenìa dei nostri giorni che litigava, come tante della sua età , con una madre arcigna e faceva della strada lo spazio teatrale della sua disubbidienza, come una volta nell’agorà del villaggio. Da noi questa ragazzetta rossa si sarebbe chiamata Teresina o Immacolata, chissà . Qui si chiama Ifigenìa anche se per me non può essercene un’altra oltre a quella nota a tutti che vive nella mitologia e non ne dovrebbe uscire!
Siamo ripartiti subito alla volta delle rovine di Tirìnto, a quattro o cinque chilometri a nord di Nà uplia. Tirìnto la nobile, la città di Perseo tante volte umiliata da Argo, la possente vicina. Tirìnto è anche la città del massimo splendore miceneo: millequattrocento anni prima di Cristo! Che resta di essa? Mura, blocchi ciclopici d’incredibile spessore e di peso impossibile. Null’altro che pietre corrose, di un colore come ruggine che dicono solo lo splendore di un passato lontano.
Lasciamo le rovine di Tirìnto per Argo, che si trova a meno di dieci chilometri, verso nord-ovest. Argo la splendente, così ricorda il nome! Essa pure evoca memorie remote. Gronda onori come un favo di miele gronda dolcezza. Memorie, miti, leggende s’incrociano qui, si contraddicono, si sovrappongono. Oggi Argo è una città di poco più di ventimila abitanti, ma è l’unica tra quelle greche ininterrottamente abitata forse da cinquemila anni. Tutta la sua celebrità è celata nelle sue viscere. Quasi orgogliosamente la terra egoista nasconde il profumo del suo mistero nel giallo delle biade. Argo era la città di Dà nao, padre di cinquanta figlie, assassine degli sposi-cugini condannate all’eterno esercizio del riempimento di vasi senza fondo negli Inferi. Ma era anche la città mitica del ciclo dei Pelopidi, la città della vendetta di Oreste, la città storica più potente del Peloponneso del IV sec. a. C., quella che distrusse Micene e Tirìnto. Oggi, oltre al nome che è il suo vestigio più glorioso, non restano che alcuni mosaici e qualche scultura d’epoca romana conservati nel museo archeologico. Solo io e il professore ucraino di greco antico, Nagorniuk, abbiamo osato affrontare i dardi del sole argivo. Il professore con volontà anche più coriacea della mia. Difendeva la pallida fronte con una bandana bianca bagnata mentre decantava i bronzi sconosciuti di Policlèto, nativo di qui e declamava versi eroici di Tirtèo con voce ispirata.
Le rovine di Micene sono a circa dieci chilometri a nord di Argo. Ci arriviamo intorno alle due del pomeriggio. In cielo un sole furioso non tempera la mia impazienza di riempirmi la vista di quella luce che gli occhi colmò, più di un secolo fa, a Schliemann, scopritore dei suoi tesori.
Neanche di Micene resta molto. Il moderno villaggio che, senza riguardi, ne conserva il nome si trova a poca distanza dalle rovine della città antica che si adagia tra il Monte Zara e l’Agios Elias. Sono due alture che sembrano proteggerla con le loro lunghe ombre, quasi come due braccia affettuose. Il pullman si arresta a poche centinaia di metri dalle rovine. Le percorro da solo, mentre l’aria s’imbalsama di odori caldi di miele e degli aromi della terra, come il prezzemolo selvatico che spunta tra le pietre di Selinunte. Ma so che è un’impressione. Ho di certo gli occhi sgranati su quelle rocce squadrate, scorte da lontano con il desiderio di leggere in esse tracce di chissà quali segreti, vene di chissà quali mitiche trame. Sono solo rovine, invece, grigie o fulve come rame, sotto un sole che esalta gli odori, li scompone, li rende perfino sgradevoli per quella confusione dei sensi che per emozione, talvolta, accomuna la vista all’odorato.
I miti che concernono Micene sono molteplici. Secondo quelli più antichi, la città sarebbe stata fondata da un tale Micenèo e fortificata da Perseo. Secondo Omero, invece, sarebbe stata edificata dalla ninfa Micene, di incerta origine. Miti paralleli, ma sicuramente più radicati e noti, fanno risalire la fondazione della città a Perseo. Costui era nato dalla sconvolgente unione di Zeus e di Dà nae, figlia di Acrìsio, signore di Argo. Sconvolgente per i motivi che sto per dire. Narra il mito che un oracolo aveva predetto a questo re la sua morte per mano di un nipote, figlio di sua figlia. Per nota che fosse agli antichi l’ineluttabilità del Fato, pure, costantemente, essi facevano di tutto per contrastarla. Per prevenire l’evento, Acrìsio rinchiuse perciò Dà nae in una caverna sotterranea così che non potesse avere possibilità alcuna di incontrare un uomo. Ma, come ho detto, il Fato non conosce ostacoli. Zeus stesso, invaghitosi della giovane, si trasformò nientemeno che in una pioggia d’oro e con lei si unì in questo modo fantasioso. Quante sono le avvincenti tele dedicate a questo soggetto, a cominciare da quella celeberrima di Tiziano! Così Acrìsio, per scongiurare il pericolo che gravava su di lui, non trovò migliore soluzione che scaraventare in mare, madre e figlio, chiusi in una cassa. Essa però approdò all’isola di Sèrifo il cui re, preso d’amore per Dà nae, allontanò Perseo dalla sua reggia spingendolo a sopprimere la sola mortale delle tre Gorgòni, Medusa, che con lo sguardo pietrificava chi osava fissarla. Perseo con uno stratagemma riuscì a uccidere Medusa e portando con sé la testa, fatto ritorno a Sèrifo, pietrificò il pretendente della madre. Si recò poi ad Argo da dove il vecchio Acrìsio, preso da terrore, era già fuggito per nascondersi a Là rissa, in Tessaglia. Qui, nel corso di una gara cui aveva partecipato anche Perseo, il re incalzato dal destino, morì colpito accidentalmente dal disco scagliato proprio dal nipote, che un colpo di vento aveva fatalmente deviato.
Per erigere le mura di Micene Perseo si era avvalso dell’aiuto dei ciclopi. La città trarrebbe il suo nome da mykes, ossia fungo, perché del cappello di un fungo l’eroe si sarebbe servito, come di una coppa, per dissetarsi. Questo simbolo si ripete nel pomo delle spade micenee. La città fu governata dai discendenti dell’eroe fino a Euristèo, che fu l’ultimo dei Persèidi, quello stesso che impose a Eracle le dodici fatiche. A questa dinastia seguì quella di Pélope, progenitore di Tieste e Atrèo, di Agamennone e di Oreste, suo figlio.
Micene, con Argo e Tirìnto, fu il centro più potente della civiltà micenea, fiorita in Grecia tra il milleseicento e il milleduecento a.C. A essa è indissolubilmente legato il nome di Agamennone, mitico e sventurato re della città . Di Micene Omero tracciò il profilo di città superba e ricca di oro. E oro colato erano tutte le affermazioni del poeta per la credulità folle e geniale di Schliemann che, dopo aver scoperto Troia, qui venne è prese a scavare con la certezza nel cuore di trovare la conferma alle parole di quello. E la trovò la conferma. Poco si sapeva di Micene prima di lui. Semisepolta era la cosiddetta Porta dei Leoni (ma più opportuno sarebbe chiamarla Porta delle Leonesse, vistane la forma), che era l’ingresso di un centro fortificato cinto da mura spessissime, alte talvolta fino a tredici metri e dominato dall’acropoli. Qui la cocciuta determinazione di Schliemann ebbe ragione della scienza degli archeologi paludati. Proprio alle spalle della Porta dei Leoni portò alla luce un ampio tolos, ossia una costruzione circolare, che era anche il cimitero reale della città , noto come il circolo funerario A. In esso egli rinvenne sei tombe con intatti gli straordinari corredi funebri che si conservano oggi nel Museo Archeologico di Atene. Fra gli altri notissimi pezzi Schliemann scoprì una maschera funeraria d’oro, cui ancora erano attaccati brandelli di pelle. Lo scopritore, nella sua esaltazione, non dubitò che fosse quella di Agamennone. E con questo nome essa è ancor oggi nota.
Ho seguito solitario il percorso che dalla Porta delle Leoni sale verso l’Acropoli. A destra si distinguono le tombe reali portate alla luce da Schliemann, seguono poi basamenti di costruzioni che dovevano essere imponenti. Fra esse quelle di un palazzo con un vasto mégaron, ovvero un’ampia sala dove i sovrani davano le loro udienze. Proseguo salendo fino al palazzo detto di Agamennone, che si trova poco sotto la cittadella e poi, ancora più su, fino al grande cortile (forse ancora un mégaron) alla sommità di essa e più oltre, fino alla stanza dove, per arricchire il fascino delle memorie, Agamennone sarebbe stato trucidato da Clitennestra, la sposa infedele…
Immaginare, credere, sognare! Chissà cosa conviene. Ma non è questo il punto. Occorre, secondo me, sentire, sentire un po’ alla stregua di Schliemann e solo allora quello che non esiste si crea, si forma sotto gli occhi. E riesci a vedere Clitennestra, il suo braccio omicida che Egìsto sostiene mentre colpisce alla schiena lo sposo. Superbo di gloria, questi tornava da Troia con la schiava amante, Cassandra, profetessa non creduta, che pure questa efferatezza aveva invano predetto.
Muto per l’emozione lascio queste pietre cui solo la mia illusione dà un profilo e un valore. Mi allontano per raggiungere il gruppo e visitare il cosiddetto Tesoro di Atrèo, anche noto come Tomba di Agamennone. Si tratta di un enorme cumulo di terra, rivestito all’interno (che ha forma di cupola), di blocchi di pietra arenaria sempre più piccoli a mano a mano che ci si avvicina alla sommità e uniti senza malta. Al sito si accede seguendo un lungo dromo, un corridoio scoperto e dopo aver varcato una porta monumentale sormontata da un architrave sul quale si apre uno squarcio triangolare di alleggerimento.
Nel brusio dei commenti, sulla via del ritorno, ho ascoltato distratto tutte le aggiunte del professore Nagorniuk, che ripeteva nomi antichi come pronunziasse dei mantra e batteva la pipa di terracotta nel palmo della mano per ficcarla poi nella tasca sulla manica della giacca di pelle… Fantasie e altre fantasie evocate da appellativi di eroi e di dèi. E io che non sono cretese, non sono spartano, non sono miceneo e forse non provengo nemmeno dalla Magna Grecia, ecco, mi sono trovato al centro di un’Ellade fatta di tanti popoli che questi miti e queste fantasie hanno concepito con il loro genio, genti di cui forse ho misteriosamente chiuso il cuore in petto.
Tardissimo è avvenuto il rientro ad Atene, mentre ancora il professore ucraino declamava inascoltato in greco antico e a occhi chiusi. Così, mezzo assonnato e come ubriaco, se ne stava con la fronte ancora stretta nella bandana bianca che avrebbe dovuto difenderlo dal sole di Argo, la splendente. A me piaceva invece immaginare che fosse lì per proteggere il contenuto prezioso di quella sua piccola testa dalla memoria tenace.
Me ne sono andato in giro per tutta la mattinata nel quartiere di Psiri dove mi hanno detto che avrei finalmente trovato negozi che vendono chitoni, pepli e himation. Ho percorso in lungo e largo stradine tortuose e quelle limitrofe di Monastiraki. Ho chiesto cento volte e cento volte ho dovuto usare il meglio del mio accento per pronunciare bene chitone, hhhiton, con un’acca iniziale profondamente aspirata, difficile da far intendere. Ho percorso tutta la tortuosa Odos Ifaisou, tutto l’Ermou fin quasi al Ceramico, ma di chitoni e pepli neanche l’ombra. Solo per un istante ho sognato. Un venditore ambulante di frutta dagli occhietti vibranti mi ha subito capito e riconosciuto. Con la consueta espressione che identifica gli italiani da queste parti, stessa razza, stessa faccia, mi ha spiegato che di chitoni e di pepli avrei potuto trovarne solo in un negozietto in Odos Agia Tekla, non lontano. Ci sono andato naturalmente, con passo svelto, ritornando su quelli già fatti, tra suoni cupi di outi, che sono dei mandolini giganti, e odori di cialde profumate di miele e di alloro.
Sono giunto al negozietto che mi era stato indicato. Ma si trattava solo della bottega di un calzolaio. Ho pensato per un attimo che il venditore ambulante si fosse preso gioco di me. Tuttavia osservando nella vetrina ho capito che qui c’era un calzolaio importante, un calzolaio che era addirittura un poeta.
Ne ultra sutor crepidam judicaret… (il calzolaio non giudichi quanto c’è oltre la suola). Questa fu la replica di Apelle, il pittore di Alessandro il Grande, a un calzolaio che, dopo aver criticato i calzari mal dipinti in un suo quadro, trovò da ridire anche sul piede. Scopro che questo ciabattino di Odos Agia Tekla è un delicatissimo artista e può sicuramente andare oltre la suola, con autorevolezza. Si chiama Stavros Melissinos e le sue poesie sono tradotte in tutte le lingue così come i suoi sandali che sono famosi in tutto il mondo, non meno del suo negozietto visitato dai personaggi della ribalta internazionale, tutti i giorni.
Un negozietto, ho detto, e anche modesto, con due vetrine velate e una robusta saracinesca a maglie fittissime. Era ancora chiuso quando sono giunto e ho potuto con difficoltà dare uno sguardo all’interno. Non ho scorto nulla di particolare. Un peplo però c’era, indossato da un manichino. Si capiva che era un costume teatrale. La polvere tra le pieghe ne offuscava il colore bianco originale.
Sono andato via come un Tersìte bastonato e ho preso la Vasilissis Sofias per recarmi al museo Benaki.
Antonio Benakis, che visse a cavallo tra il milleottocento e il millenovecento, fu un personaggio di spicco della politica e un profondo cultore della cultura ellenica e delle sue tradizioni. Donò alla città di Atene, unitamente alla splendida dimora, divenuta sede del museo attuale, le sue collezioni d’arte e i reperti archeologici raccolti con passione durante una vita e in parte ereditati.
Ho visitato il museo con le sue preziose raccolte e i suoi capolavori d’arte. Mi hanno incuriosito soprattutto i reperti dell’età neolitica risalenti al seimilacinquecento a.C., assolutamente straordinari per l’unicità . Ma non meno interessante m’è parsa pure la raccolta dei vasi attici con figure rosse su fondo nero e le innumerevoli statuette fittili dette tanagrine, ricollegabili a modelli ritrovati nelle tombe della cittadina di Tanagra. Sono statuette minuscole di splendida fattura che rappresentano corpi femminili avvolti in eleganti pepli pieghettati e lunghi chitoni secondo la moda greca del IV sec. a.C. Tipi simili di sculture sono stati rinvenuti in abbondanza in Campania e un’ottima raccolta è esposta nel Museo Campano di Capua.
Ma oltre alle selezioni di reperti antichi, il museo Benaki è ricco di infinite altre testimonianze artistiche e capace di appagare anche le curiosità culturali più sofisticate. Ai piani superiori sono esposte in diverse sale icone tra le più antiche, a partire dal XIII sec. fino al XVI, la maggior parte proveniente dal Monastero di Santa Caterina sul Sinai. Stupefacente in questi dipinti è la vivacità dei rossi e degli scarlatti delle tuniche della Vergine, immersi in sfondi dorati e luminosissimi. Anche per chi non sente particolarmente il fascino della pittura bizantina come me, non è facile nascondere l’impressione che la forza di certe figure sa evocare. Ancorché statici e legnosi, i volti della Vergine e del Bambino, ripetuti all’infinito in statiche pose sono costantemente motivo di attrazione. Sai già che nella prossima icona vedrai una Vergine Tenerissima o una Vergine che Allatta o una Vergine tra gli Angeli. Il tema è stabilmente lo stesso, eppure i volti mutano, tutti hanno sfumature uniche di una dolcezza diversa e per quanto perpetuamente benedicente con l’anulare della destra piegato in maniera caratteristica, il Bambino ha una grazia sfumata e indefinibile in ogni dipinto.
Non prive d’interesse sono infine le sale del primo piano, dedicate ai costumi tradizionali delle popolazioni greche, così come i ricami, i gioielli e gli oggetti di argenteria e di ceramica. Ma che incanto ho colto nei colori sgargianti delle gonne festive delle donne di Argo e di Corinto!
Sono uscito dal museo intorno a mezzogiorno per ritornare in albergo e attendervi il pullman con gli altri escursionisti per la visita a capo Sùnion. Sono giunto con molto anticipo. C’era ancora tempo per l’ora dell’incontro e mi sono incamminato a piedi lungo la Vasilissis Sofias per raggiungere la stazione della metropolitana di Syntagma. Non ho smesso di chiedere ancora in tutti i negozi di abbigliamento dove mai avrei potuto trovare un peplo o un chitone (aspirando sempre meglio l’acca iniziale per essere ben interpretato). Immancabilmente mi hanno risposto sguardi stralunati. Solo una signora, straordinariamente elegante per l’ora, mi ha suggerito di dare un’occhiata nel quartiere di Psiri, proprio a Odos Agia Tekla, al numero che corrispondeva al negozietto di Melissinos, il poeta ciabattino… Ho sorriso incredulo e ho proseguito nel rumore dell’arteria attraversata da un traffico infernale.
Quante cose può notare chi ha il tempo di notare e quante ne esistono di cose, in alto soprattutto, che nessuno normalmente vede, tranne i viaggiatori. Ho scorto così, scritti su un muro, i sognanti versi di Hellas, di Shelley e mi sono fermato a rileggerli più volte… un’altra Atene sorgerà e a un tempo futuro trasmetterà come tramonto nei cieli lo splendore della sua primavera.
Mi sono accorto pure quanto siano scivolosi i marciapiede di Atene. Il marmo, di straordinario effetto ed evocatore di bellezze passate, in questa città è usato a profusione, ma diventa viscido solo con poche gocce di pioggia e pericolosissimo.
E mi sono reso conto pure, a mie spese, di come siano bassi gli ateniesi. La mia fronte non ha mancato quasi nessun appuntamento con le pensiline dei perìptera, i chioschi dei giornalai.