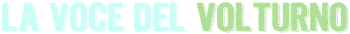M. LUISE, IL FIUME NARRANTE. VITA E MITO ALLA FOCE DEL VOLTURNO,

Recensione di ALFONSO CAPRIO a M. LUISE, Il fiume narrante. Vita e Mito alla foce del Volturno, Caserta, Spring Edizioni, 2017, pp. 239.Â
Mario Luise pubblicò Il fiume narrante, una decina di anni fa esattamente nel 2009, oggi lo ha ristampato, essendosi esaurita la prima edizione, a cura della casa editrice Spring Edizioni. Il volume ha subito delle modifiche sia nella copertina sia nella grafica, che nel testo scritto, dove sono state fatte delle aggiunte con l’inserimento di nuovi capitoli, come Il vaso di Pandora e Chopin.
In copertina, il titolo Il fiume narrante e il sottotitolo Vita e Mito alla foce del Volturno, restano invariati ma rinnovato nella fotografia, infatti, non troviamo più la testa del dio Volturno, riproposta nell’Appendice, ma una coppia di cavalieri d’Italia, fotografati da Ciro De Simone, durante un abbraccio di preludio all’accoppiamento. Il volume ha una Premessa iniziale ed è stato diviso in 27 capitoli, con un’Appendice fotografica finale nella quale sono state inserite nuove foto.
La nuova immagine di coperta intitolata Cavalieri innamorati sovverte in parte la narrazione della prima edizione, se in questa, il protome di arco raffigurante la bella testa inghirlandata del dio Volturno e la foto finale dell’ansa su cui era stato costruito il centro storico della nostra città , ci facevano capire che il protagonista dell’intera vicenda era il nostro fiume Volturno, questa nuova foto ci fa comprendere, fin da subito, invece, non solo l’amore che l’autore porta per la nostra città ma che la prospettiva di narrazione è completamente invertita, è l’Autore stesso che si è fatto fiume, per narrarci parte di quegli eventi di storia locale, che sono memoria collettiva di chi ha vissuto negli anni della seconda guerra mondiale e della ricostruzione successiva.
L’Autore non ha quasi modificato i primi diciassette capitoli dove vengono raccontati, in un’aura mitizzata, gli ultimi epigoni morenti della civiltà contadina, una civiltà che per secoli è stata uguale a se stessa e che aveva sempre seguito gli stessi ritmi delle stagioni. Le vicende sono narrate attraverso gli occhi incantati del nostro Autore bambino, che diventa ragazzo e poi adolescente e infine uomo, senza perdere mai il contatto con quella particolare spiritualità , che ha saputo maturare in un ambiente peculiare, quale è stato appunto quello della foce di un fiume, in questo caso, il Volturno, la cui acqua che passa sotto le arcate del ponte vuole rappresentarci la vita che scorre. La fine sensibilità con cui si raccontano le vicende familiari: lo scampato pericolo per la sorella e il padre mitragliati da un caccia, la casa bombardata, l’abbandono del paese a causa della guerra, o quelle collettive: l’eccidio nazifascista dell’ottobre 1943, il ritorno dallo sfollamento, i primi giochi con ì coetanei e le alluvioni, sono tutte vicende narrate con un ritmo quasi fiabesco, come solo i nostri nonni sapevano fare quando raccontavano del loro passato intorno al fuoco, non a caso il libro è dedicato ai nipoti.
A partire dal capitolo Dalle viscere del fiume, l’autore ripercorre invece le vicende, che la nostra città ha vissuto dalla seconda metà del XX secolo ad oggi, ponendo sotto accusa quell’affarismo, che ha trovato nel totale saccheggio del nostro territorio un lucroso affare di pochi, ma che è stato praticato da molti. Ripropone alla nostra attenzione la violenza con cui la società dei consumi ha stravolto e modificato l’intero ordine sociale, economico e culturale, di quel mondo contadino di atavica memoria, che i nostri progenitori avevano saputo creare e i moderni hanno sostituito con nuovi valori a quelli patriarcali, che facendo leva su un falso mito di progresso hanno portato alla quasi distruzione del nostro territorio comunale. Lo straniamento arriva con la costruzione del ponte, che sostituisce la vecchia scafa, che per millenni aveva traghettato tra le due sponde uomini, animali e cose. Il ponte che doveva unire due mondi e invece, caso emblematico, è stato l’artefice della dissoluzione dell’universo primordiale e fanciullesco in cui l’Autore ambienta le vicende. Quelli che sono due degli emblemi del nostro territorio, il mare e il fiume, entrano in conflitto e le attività umane, caccia pesca e agricoltura e che per millenni si erano praticate intorno al corso del fiume Volturno, vengono rimpiazzate da altre attività , quelle più propriamente commerciali e turistiche legate al mare. Castel Volturno rimasta per secoli ai margini dei flussi più tumultuosi degli eventi storici durante gli ultimi secoli, è assurta negli ultimi decenni all’attenzione della cronaca nazionale, sia a causa dell’abusivismo edilizio, che non ha precedenti in altre parti del Paese, quali la costruzione delle torri di Pinetamare e poi del loro abbattimento dopo trent’anni di battaglie, sia per l’insediamento di tanti cittadini “forestieri†sul territorio comunale e non ultima la venuta di tanti extracomunitari di colore; il nostro Autore afferma in merito a questi ultimi arrivati: «Chi crede che questa sia solo una situazione locale, si sbaglia, perché è il riflesso di ciò che si muove nel mondo, coinvolgendo tutti i paesi» (p. 172).
Tutte queste vicende hanno offerto a chi scrive un angolo di visuale privilegiato, da quello di bambino, che sale su una sedia e si affaccia dal muraglione per osservare l’amato fiume, a quello di sindaco di Castel Volturno, per una rimeditazione di questi eventi di cui è spettatore e protagonista insieme. La condanna senza appello di una classe politica che ha creato una sfiducia complessiva nello Stato e che invece avrebbe dovuto essere più attento a realizzare il bene comune, perché come sostiene il Nostro: «Senza legalità non c’è sviluppo. Anzi si arretra» (p. 171). Da qui emerge un atto di accusa contro il disordine costituito dalla odierna società massificata e consumistica, che ha prodotto il dissesto idrogeologico, ha favorito la criminalità organizzata, il fiorire delle più disparate attività illegali, di enormi disagi sociali e culturali e che stenta ancora oggi ad affrontare con equilibrio e competenza la risoluzione di questi problemi.
Il libro nella sua coralità mette in scena una pluralità di personaggi; quelli più propriamente familiari sono accennati, ad eccezione del nonno Antonio a cui è dedicato un intero capitolo (Un sogno al Vicolo S. Castrese) per la singolarità della sua morte; il padre, che lo porta in campagna e gli dice di seguire le sue orme per paura delle mine, quasi a simboleggiare di dover seguire la strada indicatagli dagli avi; la madre insonne, che, durante i bombardamenti, stringe il figlio, il nostro Autore, nel caldo abbraccio della coperta imbottita; la sorella Teresa la quale gli insegna a cantare le prime canzoni, che si ascoltavano alla radio e da qui riesco a comprende l’amore che Mario ha per il bel canto; i fratelli maggiori, che lo accompagnano a scuola come nella vita; il cugino Vincenzo con il suo mitico cavallo Bayard. C’è poi tutta una serie di personaggi che appaiono immobilizzati, quasi cristallizzati, nella teca del tempo, senza, però, mai perdere la vitalità e la vivacità del contesto sociale in cui vivono e di cui riflettono la solidarietà umana e tra questi: Giuvannin’ o scafaiuolo, traghettatore di anime più che di persone all’altra riva; Mast’Obert’ con le sue macchiette e Rafel’ zà -zà , questo perché, come afferma il nostro Autore, «nonostante la vicinanza del mare, eravamo unicamente gente di fiume» (p. 77). Il faticoso lavoro manuale del tempo passato è ricordato anche nei commerci dei procidani, nei ‘mpuosto e contrampuosti dei cacciatori, nel lavoro tranquillo e silenzioso dei pescatori di anguille, nella mietitura del grano da parte dei braccianti, nella battitura ritmata dei fagioli e nella raccolta dei cocomeri.
Gli affreschi di massa, che sono rappresentati con un procedimento che va dall’esterno all’interno dell’io specifico dell’Autore, mettono a fuoco i comportamenti umani di solidarietà della sua gente davanti a episodi tragici e che non consentono all’Autore di dileguarsi nell’anonimato di una folla indistinta, per cui partecipa al comune senso del dolore, sia per i propri cari che per i “forestieriâ€, che non fanno parte della comunità in cui si vive, così per l’eccidio nazifascista perpetuato dai tedeschi l’8 ottobre 1943; all’accorrere delle persone all’arrivo di Rocco Traetto feritosi su una mina (Tutti piangevano. Ebbi paura, e scappai a casa, p. 40); al correre in aiuto all’automobile, che sfuggita al controllo dell’autista scivola dalla scafa e si inabissa nel fiume (Piangevano. Anche tutta la gente cominciò a piangere, come per una disgrazia familiare, e di tutto il paese; p. 113); alla folla che si ritrova nella casa paterna dell’Autore, a causa di un improvviso alluvione e che da fondo a tutte le provviste alimentari, il cui racconto si conclude con una battuta lampante «E’proprio over’: d’int’ ‘e guaie se fann’ ‘e meglie feste» (p. 71) e che la dice lunga sulla solidarietà umana, che esisteva allora tra le persone. Lo stesso Autore afferma: «C’era miseria, ma più allegria di oggi. E tanta speranza» (p. 97), mentre oggi tutto questo sembra mancare e ci fa sembrare quel tempo molto più bello e sereno di questo odierno. La gente che accorre ad assistere al tentativo di uccisione di una ragazza da parte di un innamorato respinto e che partecipa con aggressività alla salvezza di un proprio membro, questo perché il paese era tutta una grande famiglia e la maggior parte di essi erano imparentati tra loro.
Questa stessa gente, però, non comprende l’importanza della lotta per la chiusura dell’impianto di estrazione della sabbia dal letto del fiume Volturno e anche davanti alla morte di un bambino di quattro anni travolto da un camion, ritiene l’evento «solo un doloroso incidente di percorso da pagare allo sviluppo» (p. 134). La chiusura dell’impianto di estrazione, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal Nostro, fu come egli stesso afferma: «una grande vittoria» (p. 143), queste lo si comprende sempre con il senno di poi, perché i provvedimenti emanati allora venivano accolti «con parziale freddezza» (p. 146) e ancora oggi «molti cittadini, pur rivendicando interventi di difesa, provano fastidio a parlare delle cause che avevano genersto tali danni. Tra le quali, ovviamente, prima dell’erosione del mare, delle cave e della sabbia, c’è stata una vasta responsabilità collettiva, che ancora viene respinta, non riconosciuta» (p. 152). Questo stesso popolo è quello che dà vita alla «prima e più forte ribellione determinata dall’impatto con la realtà e dalla caduta delle illusioni» (p.135) e alla rivolta popolare del maggio 1969, che: «aveva tutti i segni rabbiosi di una inevitabile manifestazione di crisi d’identità » (p. 135).
Alla folla degli indigeni si contrappone quella dei nuovi venuti insensibile al saccheggio del territorio e incapace di comprenderne la storia passata, questo nostro territorio resta «un paese maltrattato ma non rassegnato: a volte con le gambe d’argilla; altre volte, saldo combattivo» (p. 206). La fiducia del nostro Autore, espressa nei capitoli Il vaso di Pandora e in Chopin, ci prospetta «un giorno, non lontano, un mondo ordinato, Castel Volturno risorgerà come Città Domiziana, operativa e multietnica» (p. 208), questo perché il nostro litorale «ha ancora tante risorse su cui puntare» (p. 209).
L’Autore, nel capitolo intitolato Il fiume nella mente, ha una visione notturna, quasi da estasi mistica, nella quale immagina di avere un dialogo con l’antico dio Volturno, che richiama alla mente il Dialogo della Natura e di un Islandese di Giacomo Leopardi, ma mentre in questo ultimo la Natura è raffigurata come una donna seduta a terra indifferente alle sofferenze umane, mentre l’Islandese, perseguitato dai mali creati dalla natura è convinto che essa sia «nemica scoperta degli uomini»; nel dialogo scritto da Mario, invece, il dio Volturno è rappresentato «bello» e «statuario», e la situazione è invertita, è il dio e quindi la Natura, che si lamenta di quanto gli uomini odierni gli hanno procurato con il dissesto idrogeologico, il prelievo di sabbia dal suo letto, la cementificazione delle sue rive e l’inquinamento delle sue acque, mentre il nostro Autore cerca di rabbonirlo nel rammentargli le battaglie che sono state portate avanti per la sua difesa da alcuni temerari come lui stesso, ecologisti e ambientalisti ante litteram, che guardavano, ad esempio, alla salvaguardia del territorio con la chiusura degli impianti estrattivi. La conclusione è esplicitamente consolatoria, infatti, l’Autore, a giustificare l’assalto al corso fluviale, parla di smarrimento, da parte degli uomini di oggi, della «cultura della bellezza» (p. 199) e conforta la Divinità e quindi noi stessi, con l’affermazione, «che ci sarà sempre chi continuerà a battersi per il paesaggio, e ad emozionarsi di fronte ai segni del passato. Belli o brutti che possono sembrare agli altri» (p. 201), e tutto questo potrà avvenire perché, ormai «è cresciuta una generazione molto più consapevole» (p. 202) quella dei giovani a cui L’Autore demanda l’impegno per la salvaguardia del nostro territorio. Anche in questa tenue speranza, lo Scrittore, guarda, ancora, «il mondo con gli occhi dei bambini» (p. 203), ma al risveglio sarà la moglie, donna molto più pratica e realistica del marito, a riportarlo alla realtà con l’invito a chiudere le finestre, perché attraverso di esse «Entra la puzza dell’immondizia…» (p. 205).
L’ultimo aspetto su cui ho appuntato la mia attenzione è stata la lingua utilizzata, non solo sul tono fiabesco dello sviluppo delle vicende narrate, ma anche per l’utilizzo di espressioni poetiche dialettali «era scurate notte» (p. 105), che rendono vive le storie raccontate; emblematico è il monologo della mamma, che ha scoperto il figlio al fiume e lo rimprovera, quasi fosse sulla scena di quel teatro popolare, in cui eccelle lo spirito campano e che richiama alla mente l’animo plebeo delle atellane.
E’nu’ diavol’…sta ‘nfus’ comm’a cchè… sta culun’ culun… n’attim’…vist’e nun  visti’! Quacche vota ‘e chesta ‘nce rimane e more a sciumm’… ‘stu pover’ommo’ …e  accussì – … -‘nce levamm’ ‘o pensier’!(p. 45)
C’è poi il ricordo di parole che oramai sono cadute in disuso nel moderno linguaggio dialettale, come: «vaccarielli», «palazzuole», «arete a sarracina», che oggi è diventata via Marinella, o «’a chill’att’», per indicare l’odierna Destra Volturno, che se ci pensiamo è solo un dall’«altra parte», ma perché di tutto quello che c’è oggi non c’era niente, né case, né vie, ma solo una immensa e deserta campagna; un’altra parte per indicare un altro mondo, che non c’era e non poteva pertanto che essere espresso e rappresentato con un «’a chill’att’»; perché come dice lo stesso Autore «con i luoghi ci si apparenta, come con le persone: basta avere lo stesso panorama, la stessa cornice di monti, lo stesso mare, lo stesso orizzonte» (p. 50).
Mario Luise, in conclusione, propone ai lettori un testo concepito come un libro per tutti, una rappresentazione umana in cui ciascuno di noi, di quelli che sono nati e vissuti a Castel Volturno può riconoscere se stesso e le vicende tante volte ascoltate dei nostri nonni e genitori, che oramai fanno parte della nostra memoria collettiva, che fino a ieri era solo orale e che oggi invece è diventata scritta e ha acquistato, con questo libro di Mario, la dignità di vicende storiche, degne di essere tramandate come l’epopea di un popolo, quello di Castel Volturno, e nelle quali campeggiano quei piccoli e grandi avvenimenti, quei teneri e sconcertanti personaggi del nostro vivere quotidiano, che da sempre hanno appassionano sia la nostra coscienza individuale che quella collettiva.
Alfonso Caprio                      Castel Volturno, Sala Consiglio Comunale 12 gennaio 2018