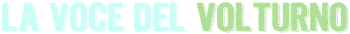UN ALTRO PIANETA DI VITTORIO RUSSO

Era stato un viaggio così faticoso che quando, finalmente, l’aereo atterrò a Freetown, alle nove di sera, non mi parve vero. Riandavo alle agghiaccianti otto e più ore di volo e mi sembrava di aver coperto distanze siderali.
Quest’impressione diventò incredibilmente concreta quando, messo piede a terra, mi accorsi di essere sbarcato su un altro pianeta.
Una luna remota in cielo sembrava osservarmi con ironia come l’unico, immenso occhio bianco della faccia di un ciclope nel nero di tenebra notturna. Vampate di calore soffocante salivano dalla pista di argento umido dell’aeroporto e da una sorte di caligine gessosa che ovattava l’aria. Ero a disagio nel sudore e per la perdita del senso dell’orientamento. Con le orecchie ancora tappate per effetto della variazione altimetrica, non percepivo che brusii lontani. Le poche persone che erano sbarcate con me, s’erano affrettate verso i banchi di controllo con i passaporti pronti e i formulari già riempiti. Era come se non esistessi per nessuno. Qualcuno mi aveva addirittura investito con la sua sacca e, girandosi m’aveva mostrato una faccia attraversata dalla cicatrice di una smorfia. Non era un sorriso. Evidentemente continuava a non vedermi.
Nella sala di controllo l’afa e l’odore di muffa mi diedero le vertigini. Addetti della dogana, della polizia di frontiera, dell’immigrazione, della sanità e chissà cos’altro, erano ad attendermi, impazienti come aguzzini pronti alle sevizie di rito. Passai attraverso i più scrupolosi filtri dei loro controlli, disposti non per vigilare ma per intimorire, ma verificai subito che anche qui dove ero sbarcato, il vile danaro risolve i problemi delle lungaggini procedurali tipici di ogni frontiera.
Poi avevo incontrato Amadou e, ancora una volta, non ebbi dubbi di essere sbarcato su un altro pianeta. Perché potessi identificarlo, teneva sospeso al collo come un condannato alla crocifissione, una tabella di legno su cui figurava il mio cognome, scritto col gesso, alla francese, Rousseau, e con caratteri sbilenchi, extraterrestri.
M’ero fatto riconoscere da lontano con un cenno della mano. Amadou (ero stato informato alla partenza che questo era il nome dell’uomo che sarebbe venuto ad attendermi), dal canto suo, aveva sollevato il labbro superiore in una smorfia leporina. Il suo benvenuto fu il sorriso oscuro che gli si era formato sulle labbra quando le aveva schiuse per mostrare una chiostra nera di denti, accuratamente limati, a sega, come quelli di uno squalo. Provai un brivido. Ricordai che anche sulla terra, da qualche parte, forse nell’arcipelago delle Touamotou o nell’isola di Kalimantan, esistevano un tempo antropofagi che si limavano i denti in quel modo credendo di rendere così più efficace la presa e la masticazione. Amadou mi aveva valutato soddisfatto sgranando due occhi bovini dove il poco nero della pupilla annegava nel bianco arrossato dell’immensa sclera.
La stanchezza del viaggio aveva a questo punto lasciato spazio a una sottile preoccupazione. Avvertivo inconsciamente che le peripezie non erano finite. Quando tutte le formalità furono finalmente completate Amadou mi venne incontro. Mi strizzò la mano in una stretta poderosa e, abbrancato il mio già tormentato bagaglio, m’indicò l’uscita dell’aeroporto con un cenno brusco del capo.
Fuori, nonostante l’ora tarda, c’era una confusione indescrivibile: venditori di tutte le cianfrusaglie più esotiche, accosciati sui bordi scheggiati dei marciapiedi; mendicanti, storpi delle deformità più assurde, forsanche provocate ad arte, come mi era stato detto, per meglio sollecitare la pietà e, infine, qualche raro europeo stralunato, piovuto dal cielo come me.
Facendosi largo a calci e gomitate, Amadou che aveva ora preso la mia valigia sotto un braccio e mi tirava per la camicia con l’altro, mi aveva fatto strada fino al luogo dove ci attendeva un’anacronistica auto. Era parcheggiata in una pozza di liquami a poca distanza da un gregge di pecore smagrite che sfumava nell’oscurità . Il nerboruto autista che ci attendeva era scalzo e sbracato. Mi fece un cenno della testa e aprì la portiera posteriore allungando una mano tentacolare come un polipo. Sentii al tatto il sedile scivoloso. Mi accoccolai riducendo al minimo i punti di contatto. Amadou si sistemò dall’altro lato, la valigia in mezzo a noi, come un cane addormentato. Mi accorsi solo allora che il fondo della vettura non esisteva più, come del resto lo schienale del sedile cui erano subentrate delle assi di legno. Mancava pure la portiera anteriore, lato pilota, il tettuccio sostituito da una struttura di compensato e i vetri. Non ci feci caso. Faceva caldo.
Partimmo nel rumore assordante di un motore che si mostrava fedele nonostante l’evidente mutilazione dello scarico e l’assenza di una candela. Dovevo far bene attenzione a non muovere i piedi se non volevo vedermeli sottratti dal morso dei ciottoli della strada che scorreva sotto di me fra le tavole, quantunque non riuscissi a vederla. Giungemmo infine a un imbarcadero. Mancava poco alla mezzanotte.
Il traghetto che ci avrebbe trasportato sulla sponda opposta del fiume sulla quale sorge la città di Freetown, era ormeggiato a una struttura di quello che un tempo era stato ferro ma che ora solo la ruggine teneva unita. Ho detto traghetto, ma si tratta di un’indicazione di comodo. In realtà era una massa scura, con una baracca di legno a proravia a indicare il posto di pilotaggio e un ammasso indescrivibile di cesti, casse, stie, pecore che occupavano alla rinfusa lo spazio a poppavia. Il tutto era marcato da un umanissimo odore di sporco.
Quando gli ultimi passeggeri furono stivati avendo trovato un posticino fra stie e casse, la chiatta si mosse con un sussulto di buona volontà , quasi orgoglioso. Avevo trovato uno spazio asciutto fra una catasta di casse, per fortuna vuote, e un cumulo nero di radici di ignami e mi ero sistemato. Intorno dominava solo la notte vigile nella luce smorta della luna, oltre a dieci facce nerissime e sudate e il rantolo, ora, del motore della chiatta da qualche parte sotto i miei piedi. Mi sentii per un momento il più fortunato degli uomini per essere ancora intatto. Sbagliavo. Amadou era seduto in posizione di cova, a un passo da me, sulla mia bistrattata valigia, quasi a volerla cosi proteggere. Offriva il profilo camuso al taglio del poco vento di traverso, fiero e meditativo come Mansa Kama, l’antico guerriero della sua terra. A tratti m’osservava con sguardi da conquistatore, ma sono certo che quei suoi occhi arrossati non mi vedevano affatto, eppure vi lessi come la mia condanna a un ignoto sacrificio tribale. Istintivamente, come per scongiurare questa minaccia e ingraziarmelo, lo distrassi dal suo raccoglimento offendigli i due gianduiotti che m’erano avanzati del pranzo a bordo dell’aereo. Li mise in bocca entrambi, con tutto l’involucro dorato, e li ingoiò. A sua volta tirò fuori dal sacchetto di pelle, che portava legato al collo, una manciata di cavallette disseccate e me ne offrì una sulla palma chiara della mano, con naturale semplicità . Si stupì perfino del mio rifiuto che mi sforzai di rendere cortese, ma che evidentemente non ero riuscito a rendere anche disinvolto. Chissà con quanto disprezzo andava considerandomi, mentre accuratamente, con dita assuefatte, spezzava gli insetti e li portava alla bocca.
Verso le tre del mattino eravamo al centro del Sierra Leone River. L’altra sponda non era ancora in vista. Il motore sotto i miei piedi ebbe uno scossone anomalo, singhiozzò qualche lamento d’acciaio, poi, rotto, tacque.
Rimanemmo così nel filo del vento e in balia della corrente. La luna sembrava contemplare spietata la mia angoscia nel vasto silenzio interrotto solo dal respiro roco dei passeggeri indifferenti e addormentati. Amadou mi scrutò con un sospiro:
«Capita!» sentenziò impietoso e fatale.
“Anche su questo pianeta…†pensai paziente.
Il capo-chiatta s’inabissò sotto coperta. Lo udii bestemmiare in temne, il suo dialetto, mentre armeggiava con mazze di ferro e altri strumenti di tortura.
Amadou dormiva ancora tutto accigliato quando – era ormai l’alba – sussultando, la macchina si riprese dal coma, ma solo perché ricominciasse la mia odissea fra tutte le galassie dell’inquietudine. Non ero stato capace di chiudere occhio ed ero in condizioni da far tenerezza a uno straccio.
Quando il fato finalmente lo decise giungemmo a Freetown. Il sole, ormai alto, dardeggiava africano e spietato. Una seconda auto ci attendeva sulla banchina, non più aggiornata della prima.
Freetown, quantunque incastonata in un panorama incantevole di acque e montagne, ha il colore omogeneo della cenere e delle erbe riarse. È una città di baracche rugginose e sghembe, ma probabilmente anche più confortevoli delle tante costruzioni di pietra, sparpagliate in giro senza ordine, in stile coloniale portoghese o krio, come si dice lì. Edificate agli inizi del XX secolo dagli schiavi ritornati dalle Americhe, queste singolari dimore non avendo beneficiato di una pur minima manutenzione, erano ormai ridotte a cumuli di pietre scolorite e fatiscenti.
Non sognavo che un letto comodo e pulito. Ma non mi facevo illusioni. Neanche per misericordia mi aspettavo di trovare ciò che in queste circostanze spetterebbe per diritto. Itaca per me, a questo punto, non esisteva più.
Avevamo percorso forse un miglio, sobbalzando a ogni scossone sulla via polverosa che avrebbe dovuto condurci all’albergo in città , quando l’auto si fermò di botto. Non mi sorpresi. Mi andavo ormai abituando. Un corteo era spuntato da una viuzza laterale, davanti a noi, e s’era immesso nella strada principale occupandola interamente. Amadou e l’autista s’erano segnati. Io li avevo imitati istintivamente o forse per scaramanzia, pronto al peggio.
Si trattava, invece, di un innocuo corteo funebre che divenne quasi di colpo una colonna sterminata di essere stravaganti. Uomini, donne, bambini e animali domestici d’ogni genere, in un clangore assurdo di ferraglie di latta, di tamburi, di corni, gridavano e si disperavano in un dolore tra i più tormentosi e rumorosi di cui si possa avere esperienza. E da altre stradette, nuovi e ancora più chiassosi sciami umani e animali si riversavano nell’arteria principale. Era come se tutti gli abitanti dell’Universo si fossero dati convegno su questa Via Lattea sperduta di Freetown, per porgere l’estremo addio a chissà mai quale eccezionale nuovo Mansa Kama o fondatore di civiltà . Alla fine, a debita distanza dalla folla, si avanzò una barella portata a spalla da quattro giovani seminudi. Potei distinguere chiaramente, disteso su di essa, il cadavere di una donna enorme, fasciato dal collo ai piedi. Solo la testa era nuda e spiccava come una macchia nera nel bianco delle bende, come bianchi spiccavano nel volto grasso, due occhi spalancati e fulminatori come quelli di Medusa.
Fummo costretti a seguire la processione per tutto il percorso. Interminabile. Mai tragitto fu per me più lungo e sonnolento di quello. Mi addormentai mille volte, soffocato dal lezzo caldo delle fogne, ribollenti di marciume a cielo aperto ai lati della strada. Ma forse anche opacizzato dalle urla e dai lamenti dei manifestanti o forse dallo starnazzare di oche e dal grido di trionfo di un gallo in lontananza.
Il mio non fu sonno di stanchezza, probabilmente fu uno svenimento, quasi certamente un incubo. E nei mari planetari di quell’incubo interamente naufragai.
Quando giungemmo all’albergo avrei pianto di gioia. Invece caddi sfatto nell’abbraccio della prima poltrona in cui inciampai.
Non avevo raggiunto Itaca, ma forse ero tornato sulla terra.