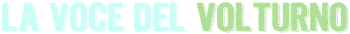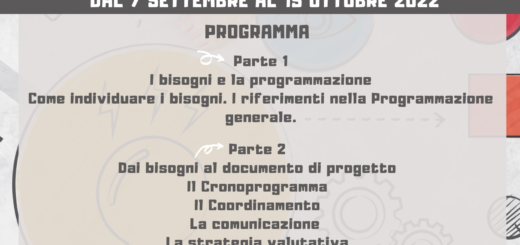Ateniesi e Atenesi

di Vittorio Russo
Per distrarre l’attenzione dalla catastrofe delle borse in cui il Minotauro Trump ha infilato le corna con la perdita di una diecina di diecina di migliaia di miliardi di euro pari a molte annate di PIL italiano, mi sono perso volutamente nella ricerca… sulle differenze che esistono tra “Ateniese” abitante di Atene (Grecia) e “Atenese” abitante di Àtena Lucana.
Ho scoperto così che il nome di Atene, capitale ellenica, è in realtà il plurale “Athénai”, equivalente di diverse città (come dire, le Atene), che erano poi soltanto antichi luoghi di culto, anche misterici, santuari e alture sacre dedicate alla dea Atena da un mitico Cecrope, re-serpente, fondatore della città. Di lui ho scritto in un lungo racconto dal titolo “Sulle ali del mito”.
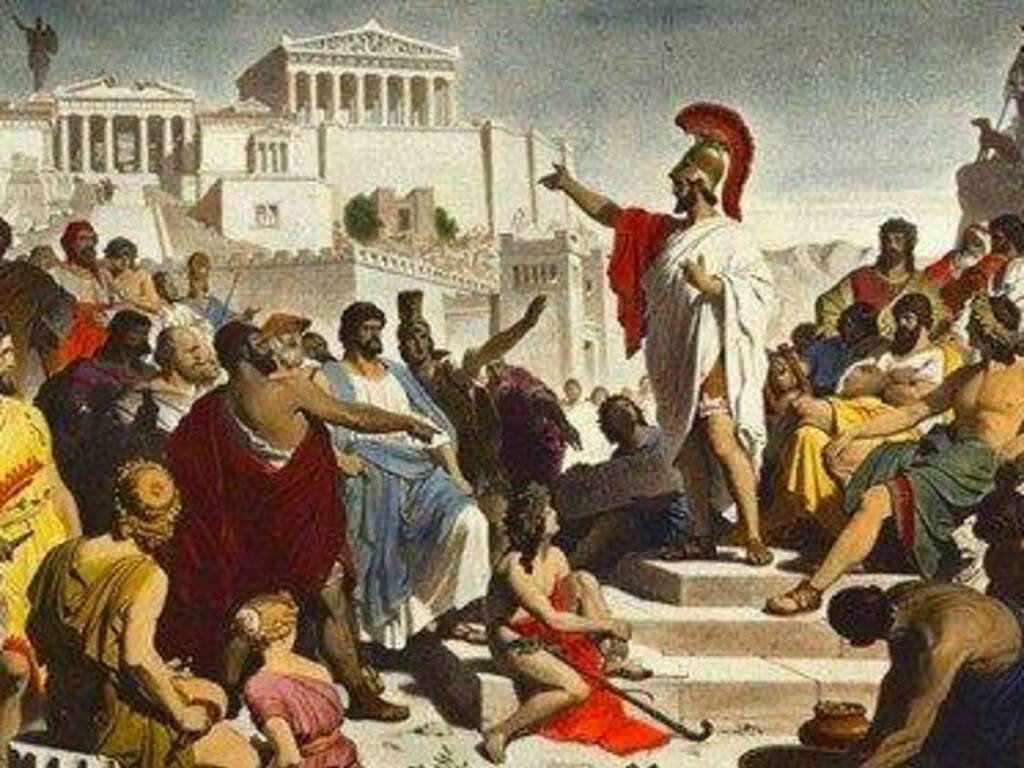
Da qui, dunque, “Ateniesi” col suffisso proprio di nomi etnici italiani.
Àtena Lucana, invece, città più “terra-terra” come diciamo noi, non ha quella nobiltà che fa la gloria della plurimillenaria Atene greca (non me ne vogliano gli “atenesi”). Àtena è una forma singolare non ricavata dal greco “Athénai”, ma dal latino “Atena”. Per cui l’etnico italiano che si forma ha il suffisso -esi come per Milano – milanesi, per Genova – genovesi, eccetera.
Per concludere il suffisso -iesi è usato per città con un’origine antica (o greco-romana) di particolare spicco e prevalentemente quando si tratta di un nome originariamente plurale.
Il suffisso -esi, invece, è comune per i toponimi italiani più recenti e normalmente singolari.

Per quello che posso dirne io, molti nomi etnici si fissano nella lingua anche per tradizione e uso. Il compianto professor Luca Serianni mi spiegò che nessuno direbbe mai “Atenesi” per riferirsi agli abitanti dell’Atene greca, anche se sarebbe comprensibile. Così come nessuno oserebbe dire “Ateniesi” per riferirsi agli abitanti di Àtena Lucana, che sarebbe considerato un “millantato credito”.
Malgrado gli inevitabili “sbadigliatori” di mestieri, che non mancheranno neanche questa volta, ritengo che quanto sopra riportato sia un piccolo ma affascinante esempio di come la lingua e la storia si intreccino in maniera inestricabile. E magari è pure possibile addentrarsi nelle oscurità più dense della storia passando per la “porta di servizio” delle parole e lo studio degli etimi di certe voci.

Intanto, per farmi perdonare dagli Atenesi” per l’apparente severità della mia analisi, preciso che Àtena Lucana è una cittadina di incredibile fascino e di non scadente antichità, almeno circa le origini del nome nel quale si intrecciano storia, leggenda e ipotesi linguistiche di grande interesse.
Per molti, infatti, Àtena deriverebbe dal latino “ater” che vuol dire “nero”, forse in riferimento a un fiume dalle acque scure che scorreva nelle vicinanze dell’insediamento.
Un’altra ipotesi chiama in causa, inevitabilmente quando si parla di antichità, il noto mito di Atteone, il cacciatore che mentre scrutava Artemide nuda bagnarsi nella acque del Fiume Nero – evocazione della notte di cui la dea era patrona – fu spietatamente sbranato dai suoi stessi cani. Il gruppo marmoreo nel Parco della Reggia di Caserta né rende una magnifica testimonianza artistica.
Un’ultima ipotesi allude a un’origine pelasgica della città, fondata da genti provenienti dal mare che avrebbero chiamato il primo nucleo abitativo col nome di Larissa, evocando quello della città di origine, Larissa in Tessaglia, essa pure di origine pelasgica.
L’aggiunta di Lucana è piuttosto recente e risale al XIX secolo a sottolineare l’appartenenza della città alla regione storica della Lucania, come si chiamava prima la Basilicata.
In sintesi, il toponimo Àtena Lucana riflette una combinazione di influenze linguistiche, storiche e leggendarie che hanno caratterizzato la regione nel corso dei secoli.
A questo punto so per certo che molti, dopo questa “tirata”, si chiederanno…: “Ma chiste nun tene proprie niente a fa?”. E sbaglierebbe di grosso, perché da fare ne ho parecchio, ma tra un capitolo e l’altro del libro che uscirà quest’anno, “lasciatemi divertire”, come scriveva il prodigioso Aldo Palazzeschi. Ma fatemi, soprattutto, stornare l’attenzione dalle follie del minotauro di cui sopra: dimostrazione vivente di quale infimo grado di disumanità possa raggiungere il cosiddetto “sapiens”. Del resto, di che stupirsi quando per crearlo fu impiegato un materiale così scadente come il fango! Che ti aspettavi che ne venisse fuori? Trump docet!
vr – 07.04.25