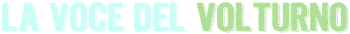“I GIOVANI E IL PLACITOâ€
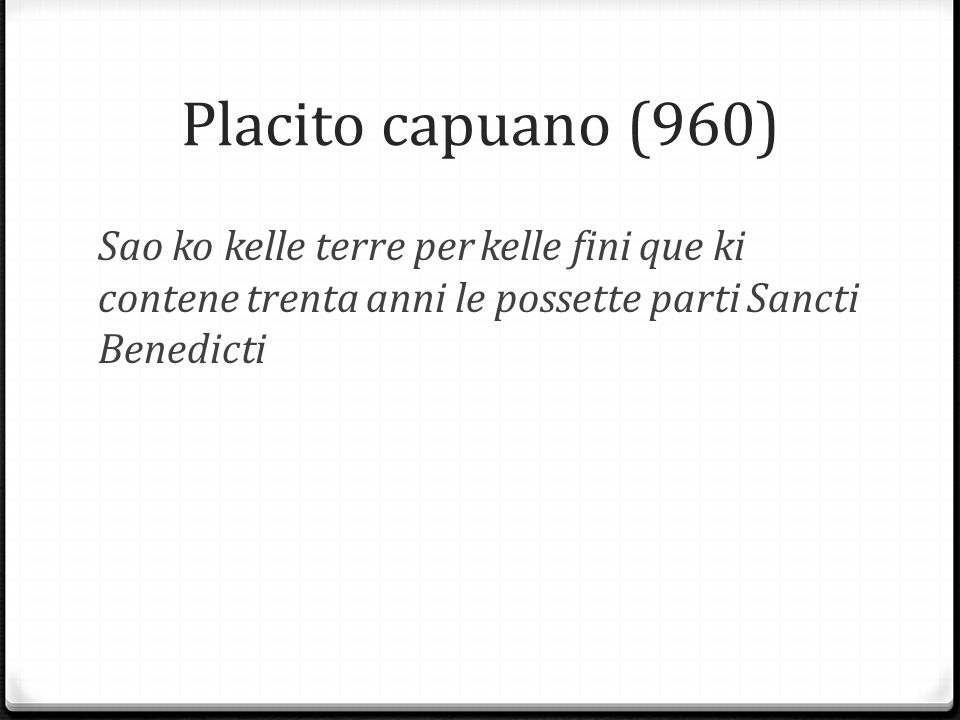
di Angela Nespoli
La piena coscienza della distinzione fra volgare e latino e l’uso consapevole del primo, in un documento scritto, si ha, nel Placito Capuano del 960, primo di quattro Placiti (detti anche Placiti cassinesi) del 960-963: si tratta di quattro sentenze giudiziarie volute dal giudice di Capua, Arechisi, in volgare perché i contenuti del discorso fossero chiari anche ai presenti ignari del latino.
Nel documento, a favore dei monaci, è trascritta la testimonianza di un chierico e di alcuni abitanti del luogo. Trattandosi di un documento ufficiale, il testo è scritto quasi interamente in latino, con abbondanza di formule giuridiche rituali. Ma, nel momento in cui il giudice ascolta la testimonianza a favore dei monaci benedettini, ne trascrive integralmente il contenuto servendosi del volgare campano, cioè della lingua usata dai testimoni stessi. Nella trascrizione il giudice ne perfeziona la forma ortografica, fornendoci così un importantissimo esempio – il primo – di uso ufficiale del volgare illustre. Si tratta, quindi, di un uso intenzionale e consapevole del volgare in contrapposizione all’ufficialità del latino. Per tali ragioni, il Placito capuano è considerato il primo vero testo in volgare italiano. Vi proponiamo la sua parte più significativa:
Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti.
Di seguito una testimonianza di un’ attività didattica realizzata dagli alunni della 3^AMM dell’ Istituto tecnico ‘FALCO’ di Capua, la conclusione di un percorso culturale e letterario portato avanti con entusiasmo e partecipazione attiva dagli alunni… con orgoglio, dico, dai miei alunni.