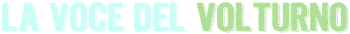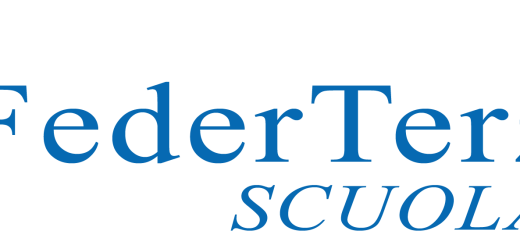IL SENO!

di Vittorio Russo
Ieri sera ho seguito la trasmissione di Augias con gli interventi di Sandro Barbero e quello di gran tono del Maestro Canfora che illustrava i simboli dell’Ara della Pace di Augusto… So bene quanto a lungo avrebbe potuto intrattenersi sull’argomento e svelare tutti i misteri e le sottigliezze di questo monumento. Ha solo potuto spiegare, purtroppo, con quanta lucidità politica Augusto sapesse orientare il pensiero delle masse facendo costruire questo simbolo di geniale propaganda

Sedate le sanguinose guerre civili, Augusto, infatti, volle lanciare un segnale potente attraverso quest’opera, una delle più superbe dell’arte del primo periodo dell’impero. Ho parlato di simboli e ce ne sono tanti impressi nel marmo del monumento (un tempo era colorato) a significare la conquistata “pax romana” e il benessere delle genti sotto l’egida di Roma.
Su una cosa il prof Canfora non si è potuto effondere, come pure mi sarebbe piaciuto, sull’illustrazione, cioè, di una delle figure scolpita su un lato breve dell’Ara, a fianco di uno dei due ingressi. Mi riferisco a Saturnia Tellus, la Dea Madre rappresentazione della prosperità che è forse il rilievo più straordinario dell’intero complesso. Rappresenta nei lineamento la bellezza classica di una dea che malgrado il disegno delle morbide linee, pure trasfonde un’idea grandiosa della “gravitas”, che non era solo maschile ma forse soprattutto muliebre presso i Romani.

Non indugio sul significato allegorico delle figure e degli oggetti che circondano Saturnia Tellus (per alcuni sarebbe invece Venere Genetrix) che sono sufficientemente comprensibili. Mi preme, invece, richiamare l’attenzione sul SENO della dea. Sì, proprio il SINUS, come lo chiamavano i latini. E qui devo intrattenermi un attimo sul suo significato autentico presso gli antichi. Il termine SINUS ci rimanda per istinto più che per filologia al seno femminile. In verità per “sinus” s’intendeva la sinuosa piega della “stola” sopra la “palla” (l’abito femminile delle donne romane), all’altezza del seno. Una piega, dunque, un morbido drappeggio, elegante e sensualissimo, reso con arte magistrale in infinite sculture. Nel rilievo di Saturnia Tellus, alla cui immagine rimando, si coglie tutta la bellezza di questo drappeggio. Sappiamo che i Romani avevano regole precise su come indossare gli abiti e ottenerne l’effetto della “gravitas” e della “auctoritas” (più autorevolezza che autorità) mai disgiunte dall’eleganze. Purtroppo, dimentichiamo questo aspetto dei costumi di Roma. La cinematografia (quell’americana soprattutto) ci ha abituati a vedere i Romani del passato costantemente come legionari dai muscoli possenti, con elmi pennuti e lucenti loriche segmentate.

Devo però dirvi di un altro SENO, quello che maggiormente catturava la nostra attenzione di adolescenti nei banchi del Nautico, quando il serenissimo prof di astronomia Buonagurio, prendeva a spiegare la funzioni trigonometriche. Quanto volentieri indugiava prendendoci per il verso più conforme alle curiosità della nostra età sul termine SENO!
Il seno di un angolo – spiegava arrotondando la mano e facendola ruotare intorno a un’ideale forma sferica – è il rapporto tra il cateto opposto all’angolo e l’ipotenusa. Però è anche altro! – soggiungeva dopo una pausa.
Uomo che del mestiere suo sapeva tutto ci spiegava che il termine “seno” in trigonometria, non è “quella cosa là” alla quale noi, per inclinazione di età, ci riferivamo. Il termine “seno” derivava da un errore di un arabista celebre, tale Gerardo da Cremona, che traducendo un testo di Al Khwarizmi (quello dal quale è nato il termine algoritmo, oggi tanto diffuso), confuse la voce “jiba”, che significa corda di arco, con “jaib”, che vuol dire, invece, scollatura e rimanda per metonimia al seno femminile propriamente detto.
In fondo la traduzione con “seno” di Gerardo va bene lo stesso perché dalla rappresentazione trigonometrica scaturisce una linea sinusoidale che ben richiama il profilo del seno femminile.
Posso aggiungere, non volendo tediarvi oltre, che grazie a spiegazioni e aneddoti come questo, il prof Buonagurio riusciva a convincere anche studenti di mediocre talento con i numeri, come me, a destreggiarsi perfino con bravura in un’arte che mi fissato dentro, fin da quel tempo, curiosità e interessi dai quali sono nati alcuni miei libri dell’età senile.
vr – 20.06.