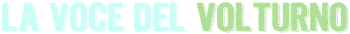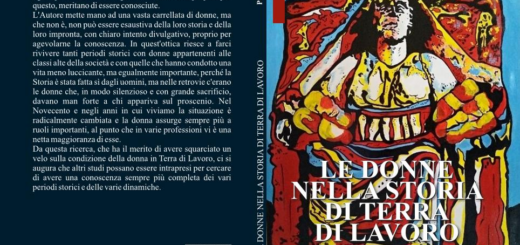INTERVISTA A ERCOLE ONGARO (co-autore del testo)-Acqua bene comune
Â
Perché avete scritto questo testo?
Come cittadino mi sono sentito interpellato dai processi in atto di mercificazione e privatizzazione dell’acqua e ho pensato che anche con la forma teatrale potevo contribuire a far prendere coscienza della pericolosità di quanto sta avvenendo in questo settore. Il primo segnale per il risveglio della mia coscienza civica mi è venuto dalla rivolta dell’acqua dei poveri di Cochabamba: quell’episodio non soltanto mi ha confermato che noi Paesi ricchi del Nord del mondo siamo causa dei disastri del Sud, del loro impoverimento nel caso specifico della privatizzazione della loro acqua, ma anche mi ha fatto intuire dove noi stiamo andando: verso un futuro che consegna beni comuni fondamentali al dominio di ristretti gruppi finanziari, permettendo loro di farli diventare una potente macchina di profitti.
Su cosa vi siete basati per costruire il testo?
Mi sono documentato, allo stesso modo nel quale mi documento per il mio lavoro di ricerca storica: ho letto molta bibliografia sull’argomento, ho studiato i documenti che il variegato movimento di resistenza alla mercificazione dell’acqua ha prodotto in diverse situazioni locali e poi ho costruito un percorso narrativo semplice ma efficace. Quanto accade a livello locale, la microstoria, è solitamente l’elemento determinante che aiuta a capire i processi generali, mondiali, e che porta al coinvolgimento personale. Il confronto con Fabrizio De Giovanni ha poi arricchito la mia ricerca e dato un ritmo al testo in vista della sua realizzazione scenica.
Ma un movimento dal basso, locale, può incidere su processi che hanno il loro contesto nella globalizzazione mondiale?
Penso proprio di sì. Può sembrare impossibile, ma proprio nel caso dell’acqua si è visto realizzato l’obiettivo per il quale il movimento di base ha lottato: dove il movimento ha saputo mantenere la mobilitazione, ci sono state inversioni di rotta impensabili fino a qualche tempo prima, si sono interrotti processi di privatizzazione già molto avanzati, si sono stracciati impegni già presi. Io stesso, che faccio parte della Rete di Lilliput di Lodi ho potuto constatarlo per quanto riguarda Lodi e il Lodigiano, dove si è passati da un orientamento privatizzatore a uno che garantisce l’acqua come bene comune. Resistere a ogni tentativo di espropriazione dei beni comuni significa salvare le basi su cui si fonda una società democratica. Mi auguro che anche attraverso questo spettacolo cresca la presa di coscienza tra i cittadini e li spinga a interessarsi alla difesa dei beni comuni in generale e dell’acqua in particolare.
Quale lezione possiamo trarre dai risultati finora raggiunti?
La certezza che la storia non è finita, che non dobbiamo farci convincere che non ci resta che la sconfitta. Sarebbe la più grande, e definitiva, vittoria delle multinazionali e del potere finanziario. Se è stato possibile invertire il vento della privatizzazione dell’acqua, vuol dire che è possibile proporsi cambiamenti di più vasta portata. E comunque è fondamentale tenere insieme i due livelli: il cambiamento delle strutture e il cambiamento del proprio comportamento, delle proprie scelte personali. Non scindere, ma coniugare i due livelli, tenendo fermo lo sguardo e la direzione del cammino verso l’utopia di una società che progetta il proprio futuro non all’insegna del denaro ma della dignità di tutti gli uomini.